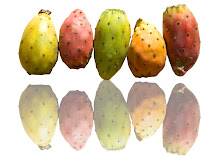«Una corte è una corte, e i cortigiani sono vil razza dannata, lo si sa dal melodramma. Ma dietro il fumo divisivo, l'avvelenamento dell'aria, la guerra di tutti contro tutti, c'è sempre un difetto di conduzione che risale al principe. Berlusconi non va in parlamento da quando presentò alle camere il governo, e sono quasi due anni. Non fa un discorso impegnativo da mesi e mesi. Non tiene ferma la barra e non la fissa con chiarezza su una rotta di iniziative e di riforme discernibile, che sia il segno esterno chiaro del significato del suo comando, della sua leadership». Non è un giornale di quelli che il premier definisce «disfattisti» a stilare questi giudizi ma «il Foglio», per la penna dell'Elefantino Giuliano Ferrara, preoccupato del rischio di una ingloriosa decadenza della leadership del cavaliere. Dunque ci si può credere, la fine dell'era berlusconiana sta entrando nell'ordine di idee dei collaboratori più prossimi del premier, non solo nei desiderata degli avversari più lontani. Quanto però a intuire, di questa fine, le modalità possibili, o a delineare gli scenari del dopo, qui l'immaginazione politica difetta, a destra e a manca. E a destra e a manca azzarda più la previsione di un'erosione interna che quella di una spallata esterna: una corte è una corte, e in linea con la regressione dell'Italia da democrazia costituzionale a monarchia assoluta sarà utile rispolverare le reminescenze shakespeariane sul marcio, il verminaio, la decomposizione che implacabilmente maturano sotto l'apparente splendore delle corti, attaccando prima prima o poi il corpo del re e il corpo del popolo nella loro unità mistica e nella loro identificazione speculare.
«Una corte è una corte, e i cortigiani sono vil razza dannata, lo si sa dal melodramma. Ma dietro il fumo divisivo, l'avvelenamento dell'aria, la guerra di tutti contro tutti, c'è sempre un difetto di conduzione che risale al principe. Berlusconi non va in parlamento da quando presentò alle camere il governo, e sono quasi due anni. Non fa un discorso impegnativo da mesi e mesi. Non tiene ferma la barra e non la fissa con chiarezza su una rotta di iniziative e di riforme discernibile, che sia il segno esterno chiaro del significato del suo comando, della sua leadership». Non è un giornale di quelli che il premier definisce «disfattisti» a stilare questi giudizi ma «il Foglio», per la penna dell'Elefantino Giuliano Ferrara, preoccupato del rischio di una ingloriosa decadenza della leadership del cavaliere. Dunque ci si può credere, la fine dell'era berlusconiana sta entrando nell'ordine di idee dei collaboratori più prossimi del premier, non solo nei desiderata degli avversari più lontani. Quanto però a intuire, di questa fine, le modalità possibili, o a delineare gli scenari del dopo, qui l'immaginazione politica difetta, a destra e a manca. E a destra e a manca azzarda più la previsione di un'erosione interna che quella di una spallata esterna: una corte è una corte, e in linea con la regressione dell'Italia da democrazia costituzionale a monarchia assoluta sarà utile rispolverare le reminescenze shakespeariane sul marcio, il verminaio, la decomposizione che implacabilmente maturano sotto l'apparente splendore delle corti, attaccando prima prima o poi il corpo del re e il corpo del popolo nella loro unità mistica e nella loro identificazione speculare.Vent'anni però, per quanto si possano contrarre nella memoria di noi che li abbiamo vissuti e patiti quotidianamente, dal punto di vista dell'analisi storica sono un tempo sufficiente a delineare un'epoca. Vent'anni durò il fascismo, dodici il nazismo, e in molti meno si sono decisi processi storici di pari entità. Dunque, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista storiografico, il berlusconismo, scrive Gibelli, «è venuto il momento di prenderlo sul serio»: non meno dell'«età giolittiana», l'«Italia berlusconiana» appare ormai compiutamente definita da un insieme compatto di coordinate riconoscibili.
Quali? Galoppando fra la genesi (negli anni 80 di Craxi), l'esordio (il dopo-Tangentopoli), il successo, gli alleati (Lega e cattolicesimo tradizionalista in primo luogo), Gibelli le riassume in modo essenziale, con il linguaggio e la sintesi di una lezione di storia rivolta a chi verrà, o a chi nell'Italia berlusconiana è nato e cresciuto e non ne ricorda o non ne immagina un'altra. Personalizzazione e spettacolarizzazione della politica, ridimensionamento del ruolo dei partiti tradizionali a vantaggio di movimenti a leadership carismatica, affermazione di tendenze antipolitiche «più durature e tenaci» di quelle affiorate in precedenza nella storia nazionale, primato della televisione nella formazione del costume e dell'opinione pubblica: qui sta la fenomenologia di quello che può a buon diritto definirsi «la manifestazione per ora più compiuta della politica post moderna» nell'Occidente democratico. Un - triste - primato in cui l'Italia torna a rivelarsi il laboratorio sintomatico di una tendenza più ampia, occidentale appunto, alla de-formazione della democrazia liberale costituzionale. Deformazione che passa sotanzialmente per l'abbattimento della divisione dei poteri, il loro accentramento in una persona sola, il ritorno di una sovranità assoluta, cioè affrancata dal controllo dei contropoteri, la magistratura in primo luogo. E' quello che sappiamo dalla cronaca. L'occhio dello storico è d'aiuto però su un punto cruciale, sul quale l'occhio dei politici e degli osservatori invece indigia e oscilla da anni: la congruità del termine «regime» per definire il berlusconismo, la legittimità del paragone con il fascismo, l'autoritarismo, il totalitarismo. Con precisione, scrive Gibelli che se è «improprio parlare di una dittatura in senso classico, è insostenibile la tesi che ci si muova nella normalità democratica»: trattandosi ormai piuttosto di una «democrazia illiberale». E ancora: «L'uso di termini come autoritarismo e totalitarismo viene spesso boillato come manifestazione di un allarmismo ingiustificato e controproducente. Quando non è frutto di conformismo, questo atteggiamento discende da un equivoco. E' chiaro che i due termini possono essere applicati solo a patto di mettere l'accento sulle forti differenze di significato rispetto ai loro usi classici. Autoritarismo non può significare in questo caso uso prevalente della forza repressiva dello Stato». Ma nel discorso politico berlusconiano «è possibile cogliere una vocazione in senso lato totalitaria»: ad esempio nella fobia per il contraddittorio, o nella sostituzione del «popolo - il tutto - al partito - la parte. Così come, se è evidente che «Berlusconi non è né Hitler né Mussolini», comuni ai tre sono elementi inquetanti di uso del carisma, dell'immagine, della fascinazione personale. Quanto basta per tentare di uscire dal ventennio prima che imploda da sé.
POLITICA O QUASI
Berlusconi, storicamente parlando
Ida Dominijanni
il manifesto 23/2/10